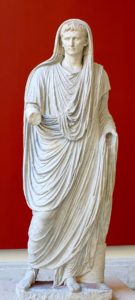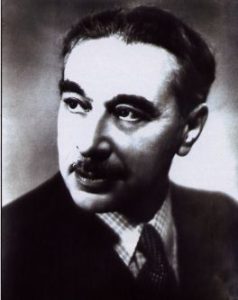Articolo-testimonianza personale per il Corso di Aggiornamento su “Dialetto e cultura contadina“. Museo della Civiltà contadina. S.Marino di Bentivoglio (ott./nov. 2005)
Sgnour a m’ trag zò ,
liverm a n’ al sò.
Casomai ch’a nu’ m ‘ livàss ,
l’alma mi a Dio a la làss,
ch’al la lìva,
ch’al la pàisa,
ch’al la métta in dù» ag’sovv .
Per chi non conosce il dialetto bolognese possiamo farne una libera traduzione in italiano:
“Signore mi corico, /se mi alzerò non lo so /. Casomai non mi alzassi, / l’anima mia a Dio la lascio, / che la sollevi, / che la pesi/ che la metta dove gli sovviene.”/
Si tratta di una breve preghiera che mia nonna recitava ogni sera come introduzione, o talvolta a chiusura, di una serie di orazioni, ovvero di preghiere canoniche , recitate a memoria in un latino un po’ deformato, tipico di chi non conosceva nè il latino nè l’italiano .
Questa breve preghiera, pur nella sua semplicità , è una piccola poesia, e al tempo stesso l’ espressione spontanea di un sentimento religioso forse più chiaro ed efficace di tante enunciazioni teologiche ufficiali .
E’ anche l’espressione di una fede di impronta fatalistica, umile e rassegnata all’eventualità , sempre incombente e quasi attesa, della morte. Ed esprime la fiducia nella giustizia di un Dio che raccoglierà le anime dopo la morte del corpo, e le saprà pesare e valutare, e metterle dove meritano, secondo il suo saggio giudizio.
La si potrebbe intitolare Testamento della sera, di autore ignoto, nato tra i contadini di un’ area bolognese/ferrarese chissà quando, e tramandato oralmente in ambito famigliare da nonne a madri e figlie o nuore per generazioni. Famiglie che si spostavano di frequente, da un fondo all’altro, da un Comune all’altro, in ambito provinciale o di aree confinanti , a causa degli sfratti ( cumbié, o commiati) che dovevano subire quando il numero dei componenti della famiglia non corrispondeva alle esigenze di braccia del fondo lavorato, e in rapporto alle bocche da sfamare, secondo gli interessi del padrone della terra. Famiglie che per secoli avevano conosciuto bene e di frequente la morte di loro componenti, neonati, bambini , giovani o adulti, per malattie improvvise, non curabili allora.
Mia nonna ( 1888-1979), si chiamava Rosa Guernelli in Barbieri, e aveva vissuto in parte a Corporeno e a Renazzo di Cento (Ferrara) , a Decima di Persiceto, e poi a Castello d’Argile, nel bolognese. Le mie bisnonne portavano i cognomi di Lanzoni e Risi, tipici di quelle zone.
Nella sua sequenza di orazioni serali a voce alta, dopo una giornata di fatiche, nonna Rosa non mancava mai di ricordare uno per uno tutti i suoi parenti defunti, genitori, fratelli o sorelle, il marito e la figlia morta in giovane età ( quante rechia meterna donis domine… ho sentito…).
Forse questo non è un modello linguistico significativo, anzi , presenta qualche carattere anomalo o contaminato, rispetto al tipico bolognese e al ferrarese; ma è un esempio significativo di religiosità popolare delle classi più umili, diffusa fino al secolo appena trascorso.
PREGHIERE E DIALETTI A CONFRONTO
Per chi volesse studiare e confrontare le espressioni religiose popolari dal punto di vista linguistico e di contenuto, in relazione alla loro collocazione geografica , faccio rilevare che alcune frasi ( o strofe) della stessa preghiera recitata da nonna Rosa, le ho trovate inserite, separatamente, in altre due preghiere che sono state rilevate da ricercatori in passato , rispettivamente, una a Bologna e l’altra a Castenaso.
Le due preghiere sono state trascritte nel bel libro “Costumanze e tradizioni del popolo bologneseâ€, pubblicato nel 1932 a cura di Oreste Trebbi e Gaspare Ungarelli , ristampato dall’editore Arnaldo Forni nel 1995.
La prima, rilevata nel territorio di Bologna , così recitava:
A lèt a lèt a vojj andèr
Tott i sant a vojj ciamèr
Tri da cò´ e trì da pì,
tott i sant j en mi fradii.
Al Sgnaur l’è al mi bòn pèder,
La Madona la mi bòna mèder,
San Zvàn al mi bòn paraint,
A spèr d’andèr a lèt sicuramaint,
Sicuramaint a j andarò
Gnent ed brott a m’insugnarò.
Se par dsgràzia an me livàss (*),
L’anma mi a Dio a la làss,
E a pregh l’Anzel Michel
Ch’am la lìva, ch’al la paisa,
Ch’al la metta a salvazian:
Sia benedatta st’urazian
E chi m’l’insgnè.
(*) La sottolineatura è per le tre espressioni quasi identiche a quelle della preghiera recitata da mia nonna, con la variante che qui a pesare l’anima è l’angelo Michele e l’orante si raccomanda di salvargliela.
Ma gli spunti per confronti non sono finiti, perchè abbiamo notato che una parte della preghiera bolognese sopra citata era nota e recitata anche in una versione ferrarese più breve; infatti, su uno di quei calendari che raccolgono proverbi, zirudelle, aneddoti e notizie varie di cultura popolare in dialetto ( al bòn ‘an fràrès / e la Fràra d’na vòlta -1993) era riportata la seguente Preghiera
â let a let a voi andar
Tutt i sant a voi ciamar
Trì da cò e trì da pìè
Tutt i sant ie mi fradii
Al Sgnor al mie bon padar
La Madona la mie bòna madar
San Zvan al mie bon parent
A sper d’ andar a let sicurament
Sicurament ag andarò
Non possiamo ovviamente garantire sull’esattezza della trascrizione, che potrebbe essere gravata da qualche refuso tipografico. Certo possiamo dire che la suddetta preghierina ha viaggiato, sulla bocca delle nostre ave, di nuovo nel bolognese, in questa formulazione:
Urazian dla sira.
A lèt a lèt a vlan andèr
tott i sant avlan ciamèr.
Tri da co e tri da pi
tott i sant ien mi fradi.
La Madona l’è mi mèder
al Sgnaur l’è mi pèder
san Lurenz l’è mi parant.
Ca posa durmir stanott
tranquillamant
Fatta salva la stessa riserva sulla trascrizione, vediamo che l’orante si preoccupa solo della tranquillità del suo sonno e si appoggia alla protezione della Madonna , del Signore e di tutti i santi, citando però san Lorenzo invece di san Giovanni. Evidentemente c’era una predilezione personale o locale prevalente.
La versione di cui sopra l’abbiamo ripresa da un recente articolo, intitolato A tu per tu con Dio ma solo in dialetto (di Martina Spaggiari, su il Resto del Carlino, 29 luglio 2005) che riferiva di una ricerca in corso, di orazioni, poesie devozionali e sermoni natalizi, raccolti recentemente dal Teatro degli Alemanni e dal Club Il Diapason, per confluire in un libro di prossima pubblicazione a cura degli studiosi Gioia e Ferdinando Lanzi.
Da un’altra fonte popolare (Agenda de Al biasadè 1987), abbiamo rilevato un’altra versione della stessa orazione, tradotta in italiano , ed evidentemente di generazione più recente, attribuita alla zona collinare di Camugnano. E qui, il montanaro e la massaia, già più acculturati, recitano così
“A letto a letto me ne andai
E quattro angeli scontrai:
Due dai piedi, due da capo,
Gesù Cristo dal mi lato,
Dal mi lato che mi disse
Che posassi e che dormissi
Che paura non avessi
Né di giorno né di notte, né nel punto della morteâ€
Tralasciando una ulteriore variante, notiamo che qui torna il pensiero della morte. e su questa incombente eventualità si incentra la seconda preghierina a cui avevamo accennato , rilevata a Castenaso, e che ingloba all’inizio un’altra frase simile a quella della preghiera di nonna Rosa, ma con l’aggiunta dell’ invocazione di Sacramenti canonici, di chiara influenza ecclesiastica.
Sgnaur am met zò,
Chi sa gnanch s’am livarò so;
Quater grazi av dmand a vo:
Cunfsian, Cumunian, Oli Santi
E la grazia dal Spirito Sant.
Come si può notare, dall’analisi-confronto di una semplice orazione in dialetto nelle sue diverse versioni , si può trovare materia per tante osservazioni sulle peregrinazioni della gente di campagna, sulle connessioni e contaminazioni dei linguaggi, su tanti aspetti umani e sociali del vivere la religiosità. Ci si può davvero scrivere un libro.
Magda Barbieri
PS Chiediamo scusa per la insufficiente presenza di una giusta accentazione e di qualche segno diacritico, ma la tastiera del nostro computer non ci consente di fare meglio