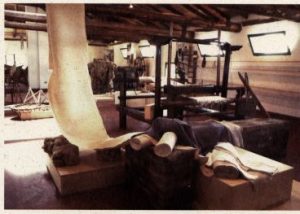Per orientarsi e distinguere i luoghi e le strade rurali e urbane, nel parlare quotidiano, gli abitanti si abituarono ad inventare e usare denominazioni spontanee o popolari che, se ben motivate e facilmente riconoscibili e memorizzabili, diventavano di uso corrente nel tempo e per secoli.
Nelle città la denominazione poteva derivare dalla presenza prevalente di botteghe o artigiani di una determinata categoria ( fabbri, orefici, lanaioli, pescherie…), o anche dalle più svariate e fantasiose motivazioni , che tramandavano la memoria di un episodio importante o curioso, la presenza di un edificio o di un’insegna particolare.
Nelle zone rurali le denominazioni popolari traevano origine spesso da caratteristiche naturali o ambientali, come la presenza di un grande albero o di più alberi della stessa specie lungo il percorso (pioppi e roveri in particolare), di un bosco, di paludi o “lame” d’acqua; a volte poteva essere la denominazione di un oratorio all’inizio della via; altre volte, anzi spesso , era il cognome della famiglia dei possidenti dei terreni adiacenti e dell’immancabile palazzotto o villa signorile, presenti per secoli, che dava identità e denominazione ad una via o a un borgo.
Capitava spesso anche che tali denominazioni popolari, nel corso del tempo, venissero storpiate o alterate per errata trasmissione orale consolidata successivamente,