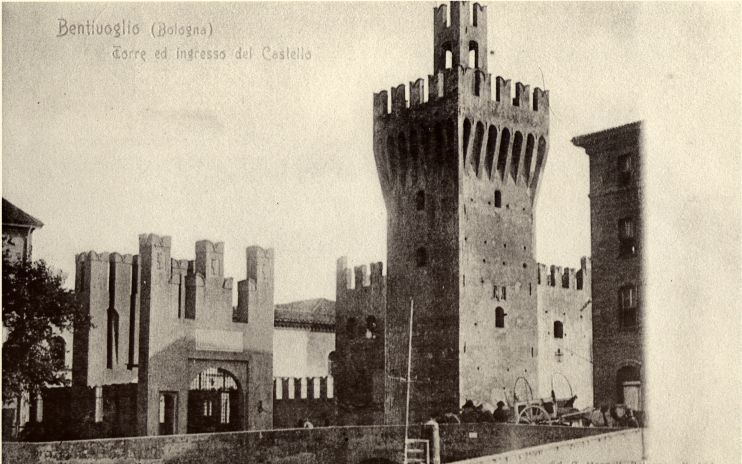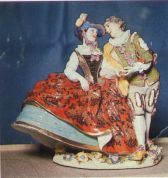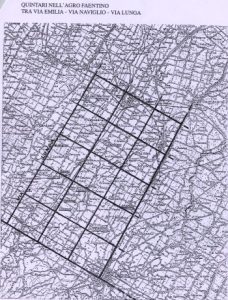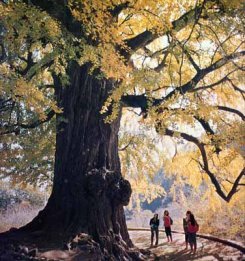E quindi uscimmo
a riveder le stelle
e ognuno di noi
cercava d’esser solo
puro e disposto
a salire alle stelle
perciò cercammo
(ma non così bene!)
l’amor che muove
il sole e l’altre stelle.
(2002)
Con questo affettuoso ed ironico plagio (avrete riconosciuto il finale dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso del nostro sommo poeta, Dante!), apriamo un ulteriore spazio in questo già ricco sito dedicato alla Pianura del Reno, dando la parola ad una delle più pure espressioni che l’intelletto umano abbia elaborato cioè la poesia.
Invitiamo tutti coloro che hanno versi chiusi nel cassetto di tirarli fuori e di portarli a conoscenza di tutti i visitatori di questo sito, perchè la storia e la valorizzazione del nostro territorio siano illuminate anche dalle parole che scaturiscono dal più profondo della nostra anima.
Il primo poeta ospitato è Mauro Franzoni (autore anche del plagio iniziale) con un suo acrostico (leggendo in verticale le iniziali di ogni verso risulterà una parola, a dare una chiave di lettura a tutta la composizione).
Nato nel 1956, laureato in Storia Antica e socio fondatore di questa Associazione, ha iniziato la sua attività poetica alla fine degli anni ’70.
Ha pubblicato le seguenti raccolte poetiche:
– L’intonaco del cielo (1986)
– Pallida eco (1991)