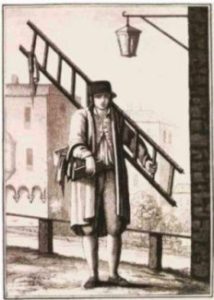Giovanni Battista Gigli, detto il ˜Tedeschino ” … da Finale. Ricerca di Galileo Dallolio
Invito il lettore a soffermarsi su questo volto. L’espressione, a mio parere, è di persona risoluta e sicura, orgogliosa del proprio talento. E’di un virtuoso di liuto nato a Finale Emilia nel 17° secolo (è in corso una ricerca sulla data), che faceva parte del gruppo ristretto di musicisti stipendiati dal Gran Principe Ferdinando 2° de’ Medici.
La sua immagine è presente in due quadri che erano nella Villa medicea di Pratolino, presso Firenze, e ora sono nella Galleria dell’Accademia
Di Gigli , lo storico finalese Umberto Baldoni nel suo Il maestro D.
Innocenzo Gigli, musicista di Finale Emilia nel XVIII secolo, Bologna
1927 lo ricordava con queste parole ˜Pro-zio gli fu quell’altro Giovanni Battista Gigli, celebre musicista finalese nel 1650, che fu ai servigi prima del G.Duca di Toscana e poi di quello
di Modena dal 1669 al 1689. Dal quale è certo ha ereditato il genio
musicale, se nessuno raggiunse nel suo tempo la fama, cui era salito
preso il nostro protagonista. Ma è stato la ricerca in corso da parte del prof. Davide Rebuffa, noto
liutista e musicologo del Centro Studi Piemontese di Musica Antica
, che ha permesso di approfondire la conoscenza di questo nostro
concittadino . Davide Rebuffa è ‘ autore del primo libro sulla storia del liuto (L’Epos,
Palermo, 2012) che, unico per ampiezza divulgativa e dettaglio
documentario, si pone come saggio di riferimento internazionale per
la conoscenza e lo studio di tutti gli strumenti appartenenti alla
famiglia del liuto e delle loro trasformazioni organologiche.
(medioevale, rinascimentale e barocco) svolgendo attività di
ricerca, concertistica e didattica ed allestendo mostre di strumenti
antichi’.
Nella citazione presente sul “Grove Dictionary of Music and Musicians” cioè
la più completa ed accreditata fonte sulla musica occidentale
vediamo che GB Gigli ha un posto nella storia della musica
(Finale Emilia; Florence, after 1692). Italian composer. No
biographical links with Germany have been found to explain his
nickname, Tedeschino, so it may simply have described his
personal appearance. He was in the service of Grand Duke Ferdinando
III of Tuscany in Florence when he published Sonata da chiesa e da
camera a 3 strumenti, col basso continuo per l’organo op.1 (Bologna,
1690), which he described as ‘an immature part of my early
composition’. He may also have worked at Modena for the Este
family, since two oratorios (S Caterina and S Genovefa Palatina), six
trio sonatas and one cantata for solo voice with continuo survive in
manuscript in the library there (I-MOe). Four pieces are also
included in a 17th-century manuscript collection of arias and
cantatas (in I-Bc), and he appears to have written a sacred history,
La libertà prodigiosa (Florence, 1692).
Presso la Biblioteca della Musica di Bologna Strada Maggiore 34 (1) si apprende
che sono presenti a Bologna le seguenti musiche di Giovanni Battista
Gigli: – un manoscritto miscellaneo, con segnatura DD.49, contenente quattro
composizioni (questo il link alla scheda del catalogo Gaspari on line
http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/scripts/gaspari/scheda.asp?id=8071)
-un’edizione, Sonate da chiesa, e da camera … Bologna, Pier Maria
Monti, 1690, segnatura Z.248. Il documento è riprodotto
integralmente e consultabile a partire dalla scheda on line
(http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/scripts/gaspari/scheda.asp?id=11581 )
Interessante la sua dedica “all’Altezza Serenissima di Ferdinando III Gran
Principe di Toscana etc. da Gio. Battista Gigli detto il Tedeschino,
Servitore Attuale della medesima Altezza. Opera Prima. Serenissima
Altezza Non crederei poter esprimere più vivamente l’umilissima mia
divotione verso V. A. S. che con rappresentarlo tale su le stampe,
prendendo la libertÃ
di dedicarle un immaturo Parto delle mie prime composizioni di
Sinfonie Musicali. Degnisi per ora l’A. V. S. come Principe di
perfetta intelligenza di gradire questo picciol tributo del mio profundissimo ossequio con benignità pari
alla sua Grandezza, che umilissimamente ne la supplico, e piova Iddio
abbondanza sempre maggiore di celestiali benedizioni e felicitÃ
sopra alla quale reverentissimamente m’inchino. Di V. A. S. Firenze
li 24 Giugno 1690. Vmiliss. Devotiss. et Obligatiss. Ser. e Suddito
GI0. BATTISTA GIGLI.
La musicologa Antonella D’Ovidio ci permette di entrare nella Corte dei Medici scoprendo altre informazioni su Giovanni Battista Gigli. Nel suo ‘Mecenatismo musicale di Vittoria della Rovere (2) (che divenne granduchessa di Toscana avendo sposato nel 1637 Ferdinando II
e che fu madre del futuro Cosimo III) si legge che Vittoria affinò e coltivò negli anni, patrocinando esecuzioni di musiche .. (ed) esercitando la sua protezione su cantanti e compositori. Tra questi si segnala nella sua corte la presenza stabile dei compositori Giovanni Maria Pagliardi, Antonio Veracini, Giovanni Battista Gigli e del cantante Ippolito Fusai, Vittoria si occupa in prima persona del reclutamento di musici, dei loro
spostamenti in altre corti e della loro protezione, intrattenendo una
fitta corrispondenza al femminile con alcune delle più importanti
donne di rango della nobiltà europea, ricreando in tal modo uno
spazio di autonomia decisionale in cui il sistema di patronage si
interseca con i rapporti diplomatici e dinastici.â€
Alla Principessa Farnese di Siena, Vittoria ‘scrive una lettera dipresentazione a favore del compositore Giovanni Battista Gigli (detto
‘Il Tedeschino’),’celebre suonatore d’arcileuto’ che sarÃ
negli anni a venire musicista a Servizio del Gran Principe Ferdinando, cui dedicherà le sue Sonate da chiesa e da camera a trestrumenti, col basso continuo per l’organo, op.1, pubblicate nel1690
Sulla sua produzione musicale nel Journal of the Royal Musical
Association (3), Antonella D’Ovidio (nel confrontare Gigli con altri
compositori) scrive ’ Similar observations may be made about the
sonatas of Giovan Battista Gigli, a virtuoso on the theorbo in the
service of Grand Prince Ferdinando; Gigli is frequently documented as
participating in the staging of operas at the Villa di
Pratolino..’Gigli’s sonatas are distinguished above all by their
brevity and concision- qualities that are evident not only within the
formal structure of these works, but also in their motivic
development’
Sulla figura del Gran Principe Ferdinando de’ Medici, nipote di Vittoria della Rovere il musicologo Gabriele Rossi Rognoni (4) scrive su come Ferdinando ‘ reinterpreti in chiave personale l’utilizzo della musica che storicamente era stato fatto dai Medici come consolidamento del suo ruolo pubblico..Tale impiego ridimensionato dal padre Cosimo III, Ferdinando infatti non si limita, come era sua consuetudine, a offrire il proprio patrocinio, o a promuovere finanziariamente celebrazioni di grande richiamo, ma giunge a scegliere personalmente soggetti, compositori, cantanti, strumentisti…p.39
In particolare , per il nostro scopo di ricerca su G.B.Gigli le seguenti parole sono preziose’ L’attività di un
gruppo di musicisti ‘personali’ di Ferdinando, regolarmente
stipendiati, emerge da numerosi documenti di pagamento: ne fanno
parte Martino Bitti, suo violinista favorito, Giovanni Battista
Gigli, tiorbista e compositore, i cantanti Carlo Antonio
Zanardi..Giuseppe Canavese e il cembalaro Bartolomeo Cristofori’p.42
(Cristofori sarà poi l’inventore del pianoforte)
In conclusione, la nonna del Gran Principe Ferdinando, Vittoria della
Rovere , come abbiamo visto, scrisse una lettera di presentazione
per segnalare il celebre suonatore di arciliuto G.B.Gigli alla
principessa Farnese di Siena, il nipote Ferdinando lo stipendiava
come musicista di corte per le varie manifestazioni musicali a
cominciare da quelle della Villa di Pratolino , inoltre lo troviamo
dipinto in ‘una testimonianza eccezionale per la ricchezza dei
dettagli dell’attività musicale privata di Ferdinando..nelle
cinque tele realizzate da Anton Domenico Gabbiani a partire dal 1685
per decorare la villa di Pratolino’ pag.44 G.Rossi Rognoni (una è nella foto n. 2) .
Se poi a questo periodo mediceo aggiungiamo il tempo trascorso alla
corte estense di Modena, su questo nostro concittadino c’è materia
per scoprire altro (chi furono i suoi maestri e chi i suoi allievi,
se ha avuto relazione con l’ambiente musicale finalese ecc.)
Nel capitolo dedicato alla Musica strumentale di Marta Lucchi (5) si legge
’Durante gli ultimi decenni del Seicento e i primi del Settecento
Modena diviene un centro propulsivo per la musica in cui si producono
contributi innovativi per la definizione delle nuove forme della
composizione strumentale’ ‘ imponente la ‘produzione
cameristica di sonate da camera, da chiesa, sinfonie, balletti
firmate non solo dai Bononcini ma anche da..Giovanni Battista Gigli e
altri’
Galileo Dallolio
P.S.
L’importante capitolo 20 (pp.389-409)’La musica a Finale’ di
Mons.Ettore Rovatti, Finale Emilia, Mille anni di storia. Vol.2
Baraldini 2012, sarà oggetto di uno studio da svolgere insieme a
Giovanni Barbi, presidente di Millenium Finalis, e con chi vorrÃ
collaborare. Barbi ha ricevuto dalla dr.ssa Furini copia
dell’inventario dell’Archivio Musicale di Finale, documento che
attesta la presenza e la diffusione della cultura musicale a Finale.
**Foto 2 ) Anton Domenico Gabbiani, Il Gran Principe Ferdinando e i suoi musici ,
1685ca., olio su tela Firenze, Gallerie dell’Accademia, Museo degli
strumenti musicali del Conservatorio Luigi Cherubini’ Nel presente
dipinto, in piedi, in primo piano,(a destra) è ben riconoscibile il
principe stesso in atto di rivolgersi al cantante Vincenzo
Olivicciani, alla sua sinistra mentre alla sua destra compare dal
fondo il busto di Alessandro Scarlatti.. sempre da destra verso
sinistra si vede un giovane con chitarrone che potrebbe essere
Giovanbattista Gigli, compositore e liutista giunto proprio nel 1685
dalla corte estense di Modena, casato i cui rapporti con i Medici e
con Ferdinando in particolare erano, in quel giro d’anni, assai
intensi. Lo stesso personaggio è raffigurato nell’atto di suonare
un mandolino al centro del dipinto seguente. (dipinto n.2 Musici del
Granprincipe..) Testo presente nella guida alla mostra ‘La musica
alla corte dei granduchi’, Firenze Galleria dell’Accademia
28.5-28.11 2001 a cura di Gabriele Rossi Rognoni
* Foto 3) Antonio Domenico Gabbiani, Musici del Granprincipe Ferdinando 1685 ca
Secondo l’autore del sito www.haendel.i t i nomi dei musicisti
sono, da sinistra: Pietro Salvetti, Federico Meccoli, Giovanni
Battista Gigli, Francesco Assolani, Giovanni Taglia, Antonio Veracini, Francesco Veracini
*** Davide Rebuffa Centro
Studi Piemontese di Musica Antica http://daviderebuffa.altervista.org/testi.php
NOTE
1)
Nella Guida al percorso espositivo del Museo Internazionale e
Biblioteca della Musica di Bologna a cura di Lorenzo Bianconi e Paolo
Isotta, 2017 si ha un’idea della ragioni per cui Bologna nel 2006 è
‘Città creativa della musica UNESCO
2)
Firenze e la musica. Fonti, protagonisti, committenza. Scritti in ricordo di
Maria Adelaide Bartoli Bacherini. A cura di Cecilia Bacherini,
Giacomo Sciommeri e Agostino Ziino, Istituto Italiano di Storia della
Musica, Roma 2014.p.283
3)
Vol.135 part.2, 2010 nel saggio’Patronage, Sacrality and Power
at the Court of Vittoria della Rovere: Antonio Veracini’s op.1 Trio
Sonatas
4)‘Il
gran principe Ferdinando e la musica, Leggi Tutto